I beni archeologici di Sorso
Alla fine degli anni 80 ( del secolo scorso) Nicola Manzoni,
allora segretario del Centro Culturale Ricreativo Sportivo di Sorso, fece,
insieme a Petronio Pani e Giuseppe Muresu, un censimento dei beni archeologici.
Il lavoro fu raccolto in un documento dal titolo chilometrico:
Proposta di censimento dei beni archeologici siti nel
territorio del comune di Sorso. Con particolare interesse verso i monumenti
preistorici, protostorici, classici, bizantini, medievali e le chiese site nel
circuito cittadino.
Il documento fu portato all’attenzione dell’amministrazione
comunale ( giunta Bonfigli 2) per un finanziamento di due milioni di lire che
trasformassero quella che era semplicemente una bozza in qualcosa di più
operativo. La proposta, malgrado la mia “ raccomandazione” ( all’epoca ero il
capo gruppo consiliare del partito di maggioranza) fu bocciata.
Ripropongo ai lettori sorsensi e anche agli altri
lettori il testo integrale: qualcosa è datato qualche altra cosa si è persa col
tempo ma rimane, a mio parere, sempre un documento interessante e una
testimonianza di amore verso il proprio paese.
PROPOSTA DI CENSIMENTO E DI ITINERARIO ARCHEOLOGICO-TURISTICO NEL
COMUNE DI SORSO
Una delle attuali
preoccupazioni di noi Sorsensi è constatare la mancanza di una documentazione,
in merito allo sviluppo culturale e storico, non solo della nostra cittadina ma
anche del suo territorio, nonostante gli antichi precedenti storici che
abbiamo avuto modo di rilevare da varie fonti letterarie. Presentando questa
Proposta di Censimento Archeologico, che è una tessera molto piccola di quel
mosaico di sforzi che stiamo producendo in tutte le direzioni, per far si di
ritrovare una nostra “ identità nazionale ed anche culturale” , purtroppo perduta nel corso della storia e di tutte le sue vicende, noi intendiamo, con
questo lavoro, arrivare a sensibilizzare i nostri concittadini riguardo non
solo i Beni culturali ma anche riguardo i Beni ambientali affinchè vengano
tutelati non distrutti.
Nicola Manzoni
Segretario
del CCRS Sorso e Coordinatore del presente lavoro
Oggi è sentita
l’esigenza del recupero dell’identità culturale ed etnica delle nostre
popolazioni. E’ viva la necessità di una presa
di coscienza della nostra storia e quindi della riappropriazione del nostro
passato e delle sue vestigia. Ciò potrà avvenire solo mediante l’elevazione culturale, da ottenere
attraverso la divulgazione delle conoscenze storiche, e più ampiamente
culturali riguardanti la nostra isola e quindi anche attraverso la conoscenza
dei beni archeologici, delle problematiche e dei risultati scientifici fin qui
conseguiti. Sarà questo un mezzo efficace per realizzare la tutela del nostro patrimonio storico, architettonico e
monumentale, paesaggistico- naturalistico. La tutela, infatti, si persegue non
con metodi repressivi ed esclusivisti, propri della burocrazia o di elite di
studiosi, ma con la partecipazione popolare alle vicende culturali.
La
valorizzazione del bene culturale e
monumentale, nel rispetto delle prioritarie esigenze scientifiche, deve
essere volta ad una funzione sociale e quindi anche ad un utilizzo in termini
economici ed occupativi.
Quando le popolazioni capiscono che i monumento sono la manifestazione tangibile della
propria storia possono essere fonte
di benessere socio- economico, allora esse stesse attuano la tutela più
efficace. ( A riguardo vedasi gli esempi dei comuni di Ittireddu,
Villanovaforru, Dorgali, tanto per citarne alcuni). Si dice che l’archeologia
sia un “ affare di Stato”, che solo
chi è inserito nelle emanazioni del potere statuale può fare archeologia e ciò
grazie ad una legge fascista del 1939, che centralizza ogni potere e ogni
autorità in materia. Nessun democratico, oggi, può razionalmente pensare di
applicare una legge superata dalla realtà e dalla storia.
Premessa
La Romangia, vista la
configurazione del suolo, con le numerose valli che si prestavano felicemente al controllo nuragico, per mezzo dei nuraghi, e alle numerose
colline calcaree nelle cui pareti l’uomo preistorico poteva assai facilmente
scavare i sepolcri per i suoi morti; e, nonostante, il fatto che il territorio
è molto vicino al mare, ricco di terre fertili, perché solcate da torrenti,
ricco di falde acquifere superficiali, favorito, quindi, da speciali condizioni
geografiche che presupporrebbero la zona prestarsi felicemente, agli antichi
stanziamenti umani, siano essi a riparo di grotte naturali o a stanziamenti
all’aperto, tali caratteristiche non rendono facile l’ubicazione dei residui
monumenti preistorici, protostorici e classici, che senza alcun dubbio
arricchivano la fertile campagna sorsense. Contrariamente a quanto farebbero
presupporre tali caratteristiche, nel territorio del comune di Sorso, non è
stato ancora possibile documentare l’orizzonte cronologico e culturale del
Neolitico Antico, Medio e Recente, culture attestate con grande quantità e
qualità di reperti, in svariate località dell’isola, talvolta meno adatte ad
accogliere stanziamenti umani.
Non è stato possibile documentare tali culture,
per diversi motivi, quali ad esempio: alle ricerche, svolte da cultori e
studiosi di archeologia, nel corso del passato secolo, fino ai primi
cinquant’anni di questo sono state condotte, nella maggior parte dei casi con
metodi non propriamente scientifici; in quanto si sono limitate alla visita
dei monumenti più appariscenti, alla raccolta superficiale di materiale
archeologico e alla catalogazione approssimativa di manufatti inerenti sia
culture protostoriche che classiche, senza che si avesse una visione completa
dei monumenti presenti nel territorio.
Tra il 1944 e il 1945 vengono intrapresi
i primi scavi, con metodi scientifici da un valente archeologo locale,
immaturamente scomparso: il dott. Mario Varsi; scavi molto interessanti in una necropoli a
Domu de Janas. In seguito alla scomparsa di questo archeologo si ha un” buco”
di ben 35 anni nei quali non si parla più di scavi archeologici ma di
ritrovamenti casuali dovuti a raccolte di superficie o in seguito a lavori
agricoli. In gran parte, il materiale rinvenuto venne disperso più per
ignoranza in materia che per malafede, o se di pregio, andò ad arricchire le
collezioni del Museo Nazionale di
Cagliari o del Museo Sanna di
Sassari.
Solo nel 1980, hanno inizio scavi molto complessi ( finanziati
dall’amministrazione comunale di Sorso
per iniziativa dell’assessore alla Pubblica Istruzione Antonio Salis e
dell’assessore ai Lavori Pubblici Leo Spanu.
Nota di LS) che hanno interessato,
soprattutto monumenti romani ed in particolare una villa in località Santa Filiddiga, che si proseguono con
alti e bassi fino al 1987, e dei relitti di navi romane, in località Porchile, che diedero degli oggetti di
bordo in bronzo di cui non si sa più niente.Tale attività ( sempre a carico
dell’amministrazione comunale. LS )interessò anche
lo sterramento di una chiesa altomedievale in località Sant’Andria, fatta distruggere dallo pseudo architetto Cano, per
attingere materiali di costruzioni per la chiesa
parrocchiale di San Pantaleo. Agli
inizi del 1988, vi fu la scoperta di un
grande insediamento nuragico, a carattere sacro, ( Pozzo sacro di Serra Niedda), costituito da un insieme di due pozzi atti a raccogliere le acque
piovane, ed una serie di strutture probabilmente riferibili ad altari e a un
villaggio; tale scavo polarizzò tutte le successive campagne di scavo.
La mancanza di un
radicale censimento dei beni archeologici che diverse amministrazioni
comunali hanno già provveduto a realizzare per contare i monumenti presenti
nel proprio territorio, mettendo a punto un piano particolareggiato, per
interventi di pulizia e valorizzazione
del patrimonio archeologico, ma allo stesso tempo, valorizzando il proprio
territorio comunale.
Già a partire dal 1980, si era intrapreso, grazie alla
buona volontà e fantasia di un gruppo di appassionati, il censimento di tutti i
beni archeologici, culturali e ambientali, presenti nel comune di Sorso;
qualità, con le quali si sopperiva ad una cronica mancanza di “fondi” necessari ad ultimare il lavoro. Tale gruppo
cercava di ricostruire l’evoluzione culturale nell’ambito del comune, arrivando
persino a sorprendenti risultati. Ad esempio, la raccolta di schede di
rilevazione per ciascun monumento, in cui erano indicate la denominazione, la
localizzazione, la tipologia, gli estremi catastali dell’area interessata, il
tutto corredato da un giudizio sintetico sullo stato di conservazione dei
monumenti in questione, in relazione alla accessibilità di un suo recupero ai
fini della salvaguardia e conservazione, nonché valorizzazione, e il tutto
corredato da una parziale documentazione fotografica. Purtroppo non si può
sempre andare avanti in qualsiasi iniziativa, con la buona volontà o con la
sola fantasia, che rimane sempre qualcosa di lodevole, del resto si andò
incontro ad una serie di spese gravose a cui non si potè far fronte. Noi
garantiamo, di effettuare oltre ad una ricerca sistematica, rivolta
all’individuazione dello stato attuale dei monumenti e alla registrazione di
quelle poco conosciute, che essi verranno opportunamente tutelati con un lavoro
scientifico. Allo stesso tempo, si garantirebbe un controllo capace di
allontanare l’attenzione dei tombaroli, dei vandali o di chi più semplicemente
ha il “folle” interesse che il monumento venga distrutto.
Infine, la sempre più
moderna meccanizzazione delle campagne che ha contribuito alla dispersione, o
per meglio dire alla distruzione di vari siti archeologici.
Breve studio sui monumenti presenti nel territorio di Sorso
Età prenuragica
Alcuni ipogei
Interessante è il
complesso a Domu de Janas sito in località conosciuta volgarmente come L’Abbiu, che è composto da ben 11
tombe, sia a sviluppo monocellulare che pluricellulare. Scavate nel calcare,
sono state parzialmente devastate dall’apertura di una strada campestre che
permette l’accesso all’omonima valle; la loro osservazione non è molto buona
sia per l’incuria in cui versano ed anche perché molte di esse, furono
manomesse nel secolo scorso. Dopo essere state vuotate del loro contenuto (
resti ossei e corredo funerario), furono riadattate ad uso di casa colonica,
per uso stalla e per custodire gli arnesi della vita contadina; ma anche modificate
utilizzando i vani sepolcrali a mò di tini per far fermentare il vino. Altre
tombe vennero distrutte perché nei paraggi vi erano delle cave da cui si
estraeva materiale per costruzione una è stata sepolta dalle immondizie in
località La Pidraia. Ben poco
materiale archeologico è stato possibile recuperare a seguito di scavi
stratigrafici, ma quel po’ che si rivenne, è risultato di grande interesse
archeologico in quanto riferibile alle culture di Bonnannaro e del Vaso
campaniforme a Cultura Beaker.
Stazioni all’aperto ( Villaggi)
La presenza
d’insediamenti umani a carattere sedentario è documentato verso la costa, nelle
pianure fertili del fiume Silis,
solcate da corsi d’acqua a carattere perenne ( l’omonimo fiume) o da corsi
d’acqua a carattere torrentizio. La stazioni o insediamenti prenuragici,
conservano gli inizi delle consuetudini civili, sociali , economiche e
religiose e ci consentono di ricostruire a sommi capi, il quadro della vita di
quelle genti primitive, nelle quali, scrive il prof. Lilliu: Persistevano
le esperienze retrive dello stadio economica, sociale di raccolta ( e naturalmente di caccia e
pesca) appena intaccate dalle nuove conquiste della civiltà agricola a carattere sedentario.
Età nuragica
I nuraghi
Ancora più sensibile è
l’assenza di elementi quali quelli tratti da un censimento sistematico sul
territorio, che potrebbe consentire uno sguardo d’assieme sugli importanti
resti dell’età nuragica. La presenza dei nuraghi è molto bassa, rispetto ad
altre zone della Sardegna; attualmente, più o meno conservati ne possiamo
contare solo dieci mentre altri 3 sono stati distrutti volutamente dai
proprietari dei fondi in cui si ergevano. Le caratteristiche architettoniche
attendono una moderna valutazione a causa dello stato di rovina di molti di
essi ma si distinguono, addossati alle torri centrali, altre strutture gemelle,
rifasci, recinti estesi lungo i crinali o inglobanti capanne, cisterne o pozzi.
Altro importante esempio, di architettura nuragica, è un superbo complesso
monumentale, a carattere sacro, venuto alla luce alcuni anni or sono in regione
Serra Niedda, e che è in corso di
scavo. Importantissimo in quanto è l’unico esempio di questo tipo di
costruzione nel circondario: Porto Torres, Sorso, Sennori, Sassari, Osilo,
Tergu e Castelsardo. Il che farebbe pensare che si trattasse di un importante “
Santuario Federale” al quale tutte le popolazioni residenti nel circondario
citato, vi si recassero per adorare i loro dei e non solo per la pratica
religiosa ma anche perché questo era un momento d’incontro tra clan diversi,
sia per effettuare scambi commerciali ma anche per stringere o rafforzare
alleanze fra tribù diverse. ( I bronzetti trovati in loco sono di varietà e
qualità eccezionali. Purtroppo anche
qui i tombaroli hanno fatto man bassa. N.d.A.)
Monte Cau o Cao
E’ una collina
calcarea, completamente isolata, al centro dell’omonima valle che termina con
un altopiano perfetto, leggermente inclinato a Nord, lungo 150 metri e largo,
al centro, 30 metri, che rastremandosi alle sue estremità dà l’impressione del
ponte di una nave. Il Pais, che
visitò il sito, così lo descrisse: Alle
due estremità vi sono gli avanzi di
due nuraghi, i quali venivano coniugati fra loro da un grosso muraglione, qua
e là costruito senza cemento tuttora riconoscibile, e che misura d’altezza
di cinque o sei metri, poggiante sulla roccia. In tale sito, furono
rinvenuti frammenti di conci di fusione, una navicella votiva in bronzo, armi,
frammenti o vasi interi nuragici, frammenti di vasi greci figurati sul fondo
nero lucidissimo, d’importazione punica, una statuetta in bronzo raffigurante
una Venere d’età romana, monete puniche e romane.
Età romana
In età romana, il
territorio gravitava nella sfera d’influenza della colonia di Turris Libisonis,
l’attuale Porto Torres, al cui porto venivano convogliati per essere spediti a
Roma, i prodotti del fertile retroterra della Nurra e della Romangia
che, anche nel nome ( Romania, Romandia,
Romangia) conserva il ricordo della colonizzazione romana. L’organizzazione
delle campagne era caratterizzata dai latifondi, di proprietà pubblica, privata
o imperiale, ai quali facevano riferimento una villa, condotta da un fattore e
costituita da una parte produttiva con gli alloggiamenti per la mano d’opera ed
ambienti per la conservazione dei prodotti agricoli, ed una residenziale che
ospitava il Dominus, quando si
recava in visita alle sue proprietà.
Alcune ville romane.
Nel territorio di Sorso sono segnalati i resti di due ville romane in
località Bagnu e Santa Filiddiga
Santa Filiddiga
E’ sicuramente la più
interessante fra le due ville in quanto è stata l’unica ad essere scavata in
modo scientifico. Il primo scavo risale al 1980 con il risultato di poter
datare la villa al periodo imperiale, In essa fu rinvenuto uno splendido mosaico
policromo costituito da: Piccole tessere
di pietra multicolore che vi disegnano
trecce che s’incrociano a formare esagoni, al centro dei quali sono raffigurati
fiori, pesci, uccelli, cesti di
frutta con un’eccezionale ricchezza decorativa. Su un lato del pavimento,
troneggiava la figura di una
divinità maschile, probabilmente Bacco. Si tratta di un esemplare unico in
Sardegna. Dietro al rinvenimento di tale mosaico, vi è una piccola storia,
uguale a tante altre che riguardano i ritrovamenti archeologici. Il mosaico
venne danneggiato dai tombaroli che ne asportarono alcune parti, inseguito
recuperate dai carabinieri di Porto Torres. ( Il mosaico, restaurato, si
trova oggi nel Palazzo Baronale di Sorso. LS)
Lu Bagnu
Lungo la strada Sorso-
Porto Torres fino a qualche tempo fa, erano visibili i resti di un edificio
termale che sicuramente sono da mettere in relazione ad una villa. L’esistenza
di un edificio termale ma più precisamente di un Balneum, nella campagna di Sorso, era nota allo Spano, che lo metteva
in relazione all’antica Gelithon, che era però ubicata in un sito diverso molto più distante da dove sorgeva l’edificio
in oggetto. Una pianta del Balneum fu eseguita dallo Spano ed è quasi completa;
si rileva una grande regolarità nella disposizione dei vani. “ Oggi, lo stato
di completa distruzione, non consente l’individuazione dei classici ambienti di
questo Balneum e cioè dei Calidarium, Tepidarium, Frigidarium e Apoditeria.”
Queste sono le parole di un archeologo che visitò il sito nel 1985. Inoltre fu
rinvenuta una lapide di marmo con un’epigrafe dedicata al Genio Villaes Comvilla che attualmente si trova nel Museo Nazionale
di Cagliari
(In un mio precedente articolo ho citato
la possibilità di un’altra villa romana in località Serra Niedda. L’ipotesi nasce dalla quantità del materiale
trovato durante le periodiche pulizie dell’area del pozzo sacro. LS)
Età bizantina
Chiesa di Santa Filiddiga
Nel toponimo della
zona-S.Filiddiga- rimane il ricordo di una piccola chiesa dedicata a santa
Felicita. Una martire africana molto venerata fin dall’età paleocristiana ma
estranea all’ambito orientale e bizantina e poco diffusa in Sardegna. Tale
chiesa a pianta cruciforme, di età proto- bizantina, costruita forse nel VI° secolo d.C., venne impiantata sui ruderi
della precedente costruzione romana.
I monumenti
I monumenti fin’ora
conosciuti si assommano a 33 e appartengono ad epoche diverse, sono più o meno
conservati e sono:
3 Villaggi pre nuragici
11 Domus de Janas
10 Nuraghi
1 Tomba nuragica
2 Altipiani fortificati
1 Santuario nuragico
2 Villaggi nuragici
2 Ville romane
1 Chiesa bizantina
BIBLIOGRAFIA
Santa Filitica a Sorso. Dalla villa romana al villaggio
bizantino. A cura di Daniela Rovina. BetaGamma editrice 2003
Il santuario nuragico di Serra Niedda a Sorso (SS), A cura
di Daniela Rovina. BetaGamma editrice 2002
Il villaggio medievale di Geridu (Sorso, SS) campagne di
scav0 1995/96. A cura di Marco Milanese. All’insegna del giglio edizioni 1996
Studi e ricerche sul villaggio medievale di Geridu.
Miscellanea 1996-2001. A cura di Marco Milanese. All’insegna del giglio
edizioni. 2004
Vita e morte dei villaggi rurali tra medioevo ed età
moderna. A cura di Marco Milanese. All’insegna del giglio edizioni. 2001
Sorso immagini. Testo
e foto di Francesco Doro. TAS Sassari. Fine anni 80?
Monte Cao: brocchetta askoide.
Santuario di Serra Niedda: bronzetto del Re- Pastore
Villaggio medievale di Geridu: boccali invetriati e boccaletto con stemma aragonese (XIV secolo)
Villaggio medievale di Geridu:poatto in maiolica policroma di Montelupo Fiorentino ( XVI secolo)
Villa romana di Santa Filiddiga: recipienti in pietra allare e marmo
NOTE
I reperti illustrati si trovano nel museo Sanna di Sassari










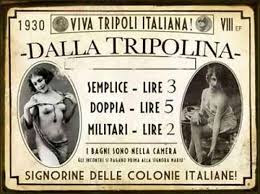
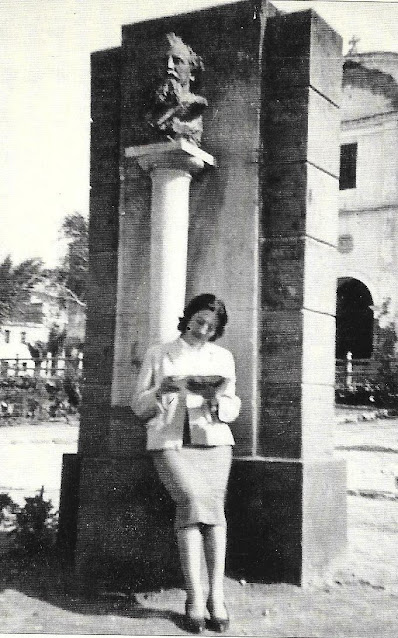



Commenti
Posta un commento